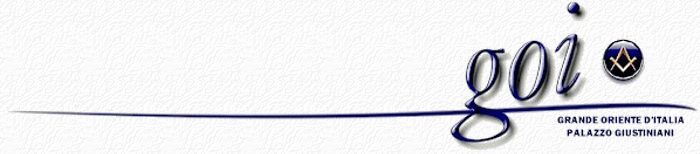Sulla pena di morte in Toscana Il Codice penale toscano Tra le molte innovazioni legislative da lui introdotte durante il suo regno, Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana, varò anche nel 1786 una radicale ed organica riforma criminale, riformulando i principi generali di politica e di procedura giudiziaria che avrebbero dovuto di lì innanzi ispirare l’esercizio della giustizia penale «nei suoi felicissimi Stati».
Con Motuproprio emesso a Pisa il 30.XI.1786, egli emanò dunque un provvedimento di portata veramente rivoluzionaria: in tale circostanza, infatti, fu da lui abolito per la prima volta in Europa l’uso della tortura giudiziaria e contestualmente si ripudiò in via assoluta il ricorso alla
pena di morte. La pena non avrebbe dovuto più mirare ad affliggere ed intimorire, ma a redimere e educare.
I circoli illuministici di tutta Europa salutarono il provvedimento leopoldino con motivato entusiasmo e profondo ed unanime consenso, ed il coraggioso provvedimento del giovane Granduca lorenese figlio del Massone Francesco Stefano di Lorena fu concordemente indicato come un vero e proprio modello di legislazione a tutti i Sovrani d’Europa. In realtà, si trattò di una primavera piuttosto effimera, perché il successore di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, suo figlio Ferdinando III, spaventato dal diffondersi di fenomeni di insorgenza sociale, avrebbe poi nuovamente introdotto la pena di morte con un editto del 30 agosto 1795 : ma, nondimeno, la «rottura» leopoldina rimase per tutti come un modello di normazione penalistica e, in Toscana in particolare, come un sicuro riferimento ideologico per i successivi interventi legislativi in materia penalistica.
Di lì a poco, a seguito dell’instaurazione dei regimi napoleonici in Toscana, e della conseguente importazione sulla riva d’Arno della codificazione penale francese del 1791, ebbe luogo anche la reintroduzione del generalizzato uso della pena di morte, inserito all’interno del severo regime penalistico francese ; in età di Restaurazione, tuttavia, tornò in vigore la mite normativa leopoldina, inasprita però dal dettato di un Editto di Ferdinando III del 22 giugno 1816, che aveva reintrodotto la pena di morte per i furti commessi da bande armate.
La tradizione della scuola penalistica classica pisana, prima con l’insegnamento di Giovanni Carmignani (che in gioventù, verisimilmente durante il periodo dell’occupazione francese in Toscana alla fine del Settecento, prima di sue scelte politiche più moderate, fu forse iniziato in Massoneria), poi con la decisa scelta e l’impegno abolizionista del suo illustre allievo Francesco Carrara, indirizzarono la politica e la riflessione criminalistica toscana lungo un solco normativo che rimontava direttamente ai valori più decisamente e radicalmente illuminati della tradizione riformatrice toscana.
Sicché il Codice Penale toscano del 1853 che fu concepito da giuristi formatisi alla luce sia della tradizione leopoldina, sia dell’insegnamento criminalistico soprattutto pisano sarebbe stato l’ultimo prodotto di una luminosa corrente di pensiero legislativo e penalistico, ispirata dall’ideale di un potere politico mite e tollerante, che deliberatamente mirava non alla soppressione od esclusione fisica del reo, ma alla sua educazione ed alla sua reintegrazione sociale.
Al nuovo Codice Penale si era arrivati per gradi. Il 31 maggio 1847 Leopoldo II di Toscana aveva costituito una commissione legislativa composta dai magistrati Bologna e Lami e dal professore di diritto penale Mori, perché da essa si redigesse il progetto del Codice Penale toscano: sul punto aveva già formulato un suo parere anche l’illustre maestro criminalista pisano Giovanni Carmignani ; Leopoldo II, inoltre, aveva già abolito nel 1847 la pena di morte per il territorio di Lucca, all’atto dell’annessione di quel Ducato al Granducato lorenese. Sempre Leopoldo II, nel 1849, al momento di rientrare in possesso del Granducato dopo l’interludio democratico del Governo provvisorio, aveva provveduto ad abolire la pena di morte che nel frattempo era stata reintrodotta da quello stesso Governo per tutto il territorio toscano ; anche se, poi, lo stesso Leopoldo II senz’altro sul filo di considerazioni politiche e d’ordine pubblico, oltre che di convenienza politica filo-austriaca nel 1852 avrebbe reintrodotto la pena di morte.
Ma il 20 giugno 1853 prevalsero ancora gli antichi ideali della stagione delle riforme, e Leopoldo II promulgò infine il nuovo Codice Penale toscano (per la materia dei delitti), ed il Regolamento di polizia punitiva per le contravvenzioni, abolendo finalmente la pena capitale.
Il Codice Penale toscano, parzialmente modificato con decreti del 1859 e del 1860, resterà (insieme al regolamento di Polizia) tra le leggi fondamentali applicate nel territorio dell’ex Granducato anche in età unitaria, fino al 1890, anno di emanazione per tutto il territorio del Regno d’Italia del nuovo Codice Penale, dovuto all’opera riformatrice ed illuminata del giurista liberale Zanardelli.
Non era stato nemmeno ragionevolmente concepibile, per il nuovo governante unitario, di interrompere la continuità normativa della temperata e filantropica legislazione criminalistica toscana. Nel 1859, infatti, all’atto dell’annessione della Toscana al costituendo Stato nazionale, i legislatori liberali e nazionali non se la sentirono di associare simile evento di evidente progresso sociale ed istituzionale alla reintroduzione in Toscana di meccanismi più conservatori ed illiberali rispetto allo standard lorenese, come quelli rappresentati dal codice penale del Regno di Sardegna, ampiamente informato all’uso della pena di morte e ad un rigorismo punitivo di marca e derivazione nettamente francese (Codice Penale del 1791).
Per cui, se i Lorena ed il loro paternalismo furono nel 1859 pacificamente banditi dalla terra di Toscana, vi rimase invece durevolmente in vigore il frutto migliore della loro tradizione politica e culturale : il Codice Penale toscano, retaggio di una mentalità politica di alta tradizione civile e di un sistema punitivo dichiaratamente mite ed illuminato.
L’opuscolo della R.^.L.^. Azione e Fede all’Or.^. di Pisa collega direttamente l’indole e l’ispirazione dei lavori condotti in quell’Officina non solo alla migliore tradizione dell’Illuminismo giuridico toscano, ma anche all’insegnamento che emanò dalla cattedra criminalistica pisana, ed accende qualche ipotesi su una continuità non solo scientifica tra giuristi pisani di possibile appartenenza e formazione Massonica come lo stesso Giovanni Carmignani che in età di Restaurazione fu pur tuttavia allineato al partito filo-lorenese, ma rimase sempre operativamente sensibile al fascino del mito riformatore di tradizione leopoldina ed i continuatori in età unitaria del loro impegno umanitario ed illuminato, come il penalista pisano Alfredo Pozzolini, sicuramente Massone, ed ampiamente impegnato nella politica democratica della Pisa di fine Ottocento. 

INDIRIZZO
ALLE LOGGIE MASSONICHE
(1862) ººººººººº La pena di morte è la massima delle pene, colla quale la società si credette finora in diritto di punire i delitti più gravi, togliendo la vita a chi se n’è reso colpevole. - Se consultiamo la storia, vediamo che nei primordii delle umane società essa si applicava frequentissimamente e per lievissime cause. Di mano in mano che quelle società progredivano nell’incivilimento, noi vediamo restringersi quella pena a sempre minore numero di delitti; di modo che oramai essa non si applica più presso le società civili che ad alcuni casi di omicidio. Questo fatto storico di per sé solo ci mostrerebbe qual sia lo scopo ultimo a cui tende, quasi senz’avvedersene, l’umana società, guidata in ciò da una specie d’istinto, che è la manifestazione della coscienza universale. Quello scopo è l’abolizione assoluta della pena capitale; e poiché quella che abbiam detto coscienza universale è ora illuminata e diretta dai profondi studii che i moderni filosofi fecero di questo importantissimo problema, è chiaro che ogni civile società si sente ora spinta con forza irresistibile a raggiungere questo fine con quel moto accelerato che l’illustre Balbo dimostrò verificarsi, come nella legge della caduta dei gravi, così nell’incivilimento.
Ma molti pregiudizii restano pur troppo ancora all’attuazione di così giusto principio. E in primo luogo la questione di diritto filosofico intorno all’assoluta iniquità della pena di morte, se da un lato può dirsi vinta nel campo astratto della scienza, lascia però sempre molti dubbi nell’animo di coloro, i quali, o timorosi o sprezzatori delle ardite teorie, prendono in prestito l’antico frasario per colorare la debolezza delle loro ragioni. Non è qui il luogo di ribattere con lungo discorso gli errori delle scuole passate, che si fecero ad infiorare coi loro sofismi la mannaja del carnefice. Basti notare che tutte si partono da un falso e inadeguato concetto del diritto individuale; tutte per quanto possano variare nelle loro manifestazioni, si restringono nell’essenza a considerare la vita (secondo le parole di Rousseau) come un dono condizionale dello Stato, che può quindi esser perduto, rinunciato, trasmesso. All’incontro la scienza moderna vede nella vita un beneficio e un diritto, che hanno radice nella stessa legge di natura; nega alla società la facoltà di togliere per qualunque causa un bene che non può dare, e del quale anzi abbisogna, come elemento necessario alla propria costituzione organica, e ordinata conservazione; professa finalmente tanto rispetto per l’individuo, che stima sacra la sua esistenza, e la pone sempre qual fine supremo di ogni sanzione legale.
Tutto ciò, si dice da alcuni, può aver peso come pura speculazione; ma le idee non valgono contro l’utilità politica e i bisogni del viver civile: è forse giunta la società a tal punto di perfezione da poter far senza di questa estrema pena? E per quanto possa oppugnarsene l’astratta giustizia, non dovrà pur troppo accettarsi, quando abbia l’attributo essenziale che ogni legge deve avere: la necessità?
Dopo tutto quello che è stato detto e scritto da insigni pensatori su questo argomento, non riescirà difficile provare che essa è priva affatto di questo carattere. - Il diritto della propria conservazione dà all’individuo la facoltà di respingere colla forza la violenza che da altri gli venga fatta, ma sempre ne’ limiti di necessaria difesa; e soltanto si giustifica l’uccisione dell’assalitore, allorquando l’assalito ha esaurito tutti i mezzi di difesa. Ora, risalendo dall’individuo alla società, non è chi non veda come questa abbia infiniti mezzi di difendersi senz’aver bisogno di ricorrere a questo estremo, e come facilmente essa possa togliere ad un individuo la possibilità di nuocere senza torgli la vita. A buon dritto si potrebbe dunque chiamare la pena di morte, un vero e inescusabile abuso di potere della società.
Ma qui i fautori dell’opposta dottrina potrebbero avvertire, che la giustizia sociale non ha solamente il diritto di punire il delinquente togliendogli i mezzi di nuocere, ma le spetta ancora l’ufficio di provvedere alla difesa preventiva de’ suoi membri, facendo che la pena rassicuri i buoni o sia di spavento ai malvagi. Il qual diritto di difesa veramente non può negarsi, ma deve esser sempre circoscritto dentro i limiti della necessità, e cessa la sua ragione di esistere dal momento in cui viola un diritto ben più alto e più sacro, qual si è quello della personalità umana. Scopo della penalità può essere soltanto di prevenire nuovi delitti, e coordinare le esigenze della sicurezza generale col possibile ravvedimento del reo. Ma come potrà raggiungersi questo fine coll’estremo supplizio? - Quanto al miglioramento dell’individuo, non è mestieri dire come la legge che calpesta ciò che v’ha di più rispettabile nell’essere umano, nulla si curi di precluder la via ad ogni estrema speranza.
E quanto al timore che coll’esempio si vorrebbe incutere, esaminiamo se e quando serva almeno il patibolo ad un risultato, che comprerebbesi a sì caro prezzo. E anzitutto facciamo osservare che il supplizio capitale è pel popolo, piuttosto che un esempio o una minaccia, un puro pascolo alla curiosità, uno spettacolo a cui assiste con più o meno emozione, come ai giuochi di forza e di destrezza. Tutti sanno quanto il popolo sia avido degli spettacoli, e specialmente di quelli che valgono a destare in lui delle vive e forti emozioni; e il popolo accorre anche a questo, ma esso ha pure molto buon senso e cuore generoso, e il sentimento che in lui desta il vedere un uomo inerme ed in catene ucciso freddamente dalla società armata contro di lui, non è certo di orrore pel delitto, ma sì piuttosto per la pena stessa; e la pietà, la compassione che svegliano in lui la posizione orribile, le pene ineffabili, e talvolta le parole commoventi del paziente, fanno sì che egli lo considera non come un delinquente giustamente punito, ma come una vittima. E il popolo generoso prende parte per lui debole, contro la società immensamente forte, e mentre scusa quello, maledice questa. E, bene fa; imperocché vittima è infatti il giustiziato del pregiudizio e della barbarie.
Questo però avviene nella parte buona del popolo, ma la parte corrotta, quella che, per cattive inclinazioni e per l’ignoranza in cui giace, maggiormente avrebbe bisogno di essere contenuta dal timore, non vede nel condannato il facinoroso giustamente punito, ma quasi un eroe che affronta la morte talvolta con indifferenza, spesso con ostentazione di coraggio spinto fino al cinismo. Di più la vista del sangue del decapitato, o delle orribili convulsioni dell’impiccato, abitua chi è inclinato al delitto a fermare senza ribrezzo il pensiero sugli atti più crudeli ed atroci, e a mirare senza commoversi gli spasimi e l’agonia di una vittima che egli forse già medita immolare alle sue brutali e feroci passioni. Ed è con questo mezzo che si crede di educar il popolo e frenarlo?
D’altra parte non vi sono tanti diversi modi di punire che meglio raggiungono lo scopo? La pena dei lavori forzati a vita non è essa forse più terribile della morte? Tanto lo è che molti preferiscono questa a quella. E, come giustamente osservava Beccaria, un uomo condannato alle galere è un esempio vivente e continuo, il che non è un giustiziato.
Ma v’ha di più. Non è d’uopo dimostrare quanto facile e comune sia nell’uomo l’errare; ora chi non vede le funeste e irreparabili conseguenze dell’errore dei giudici, quando questi sono tratti da false prove e testimonianze a condannare come reo un innocente? Né questo pur troppo è un caso ipotetico, che non uno, ma parecchi fatti di questo genere si potrebbero citare avvenuti non ha molto in Italia, in Francia ed altrove. E chi non rabbrividisce a questo pensiero? Chi non aborrirebbe per questo solo la pena di morte?
E in conferma degli esposti principii possiamo ancora addurre le luminose testimonianze della esperienza; la statistica criminale della Toscana dimostrò mai sempre come diminuirono i misfatti, accrebbe la sicurezza, s’ingentilirono i costumi in ogni periodo di tempo in cui fu cancellata dalle leggi questa sanguinosa pena.
Conchiudiamo dunque che l’estremo supplizio, lungi dal trovare alcun fondamento nella ragion filosofica, è la più barbara negazione del più sacro fra i diritti; che d’altra parte non può affatto giustificarsi nel campo pratico del diritto criminale, ammantandolo sotto il velo di una politica necessità; che finalmente considerato nella sua qualità di pena, non corrisponde menomamente allo scopo a cui s’indirizza; poiché in cambio di atterrire i malvagi e rassicurare i buoni, conturba e infierisce gli animi, e li spinge al delitto, e in cambio di migliorare il colpevole e renderlo alla società, il che è l’objetto delle pene afflittive e della giustizia criminale, commette all’uomo fallibile di pronunciare sull’uomo una irrevocabile condanna, la quale trascende i limiti dell’esistenza terrena, come viola le leggi della progredita civiltà.
L’Italia, che vanta nell’immortale suo Beccaria il primo che osò combattere di fronte il supplizio capitale, l’Italia, che si accinge ora dopo lungo servaggio, a riprendere il posto che le si compete tra le nazioni, l’Italia deve solennizzare e consacrare questo suo risorgimento, proclamando e mettendo in atto quei principii umanitarii che sono ormai da tutti riconosciuti e accettati.
Si faccia dunque una petizione al Parlamento, e si raccolgano nelle città, nei villaggi, nelle campagne tante firme che il Parlamento non solo, ma il mondo intero abbiano a ritenere quella domanda come l’espressione concorde della volontà nazionale. Sarà questo un Plebiscito, che per l’umanità intera e pel progresso avrà più importanza che quello che statuì l’unità d’Italia. Le altre nazioni seguiranno bentosto il nostro esempio, e noi avremo la soddisfazione di aver fatto un’opera santa quanto altra mai, e i posteri ci benediranno e ci diranno benemeriti dell’umanità.
La Loggia - Azione e Fede - all’Oriente di Pisa. Da: www.grandeoriente.it |
|